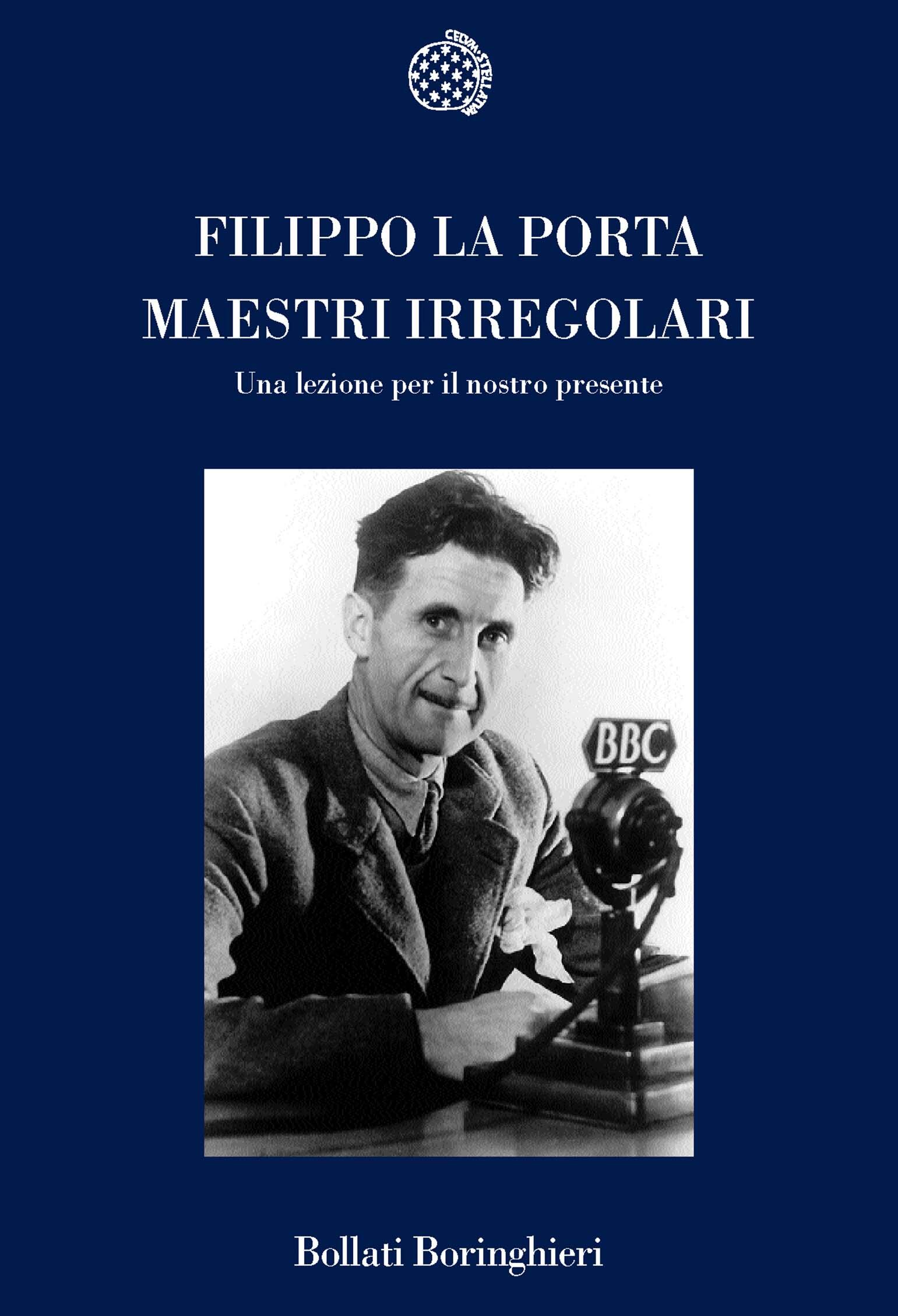«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene
Archivio articoli
Il riconoscimento può diventare una svolta o ridursi a folclore. Tra filiere in crisi, perdita di saperi e prezzi iniqui, la sfida è trasformare i valori evocati dall’Unesco in politiche concrete ed educazione alimentare diffusa.
Tommaso Martini *
La pagina del sito del Ministero della Cultura dedicata alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco dichiara che «la candidatura non riguarda un singolo piatto o una ricetta, ma un modello culturale condiviso, fatto di esperienze comunitarie, scelta consapevole delle materie prime, convivialità del pasto, trasmissione dei saperi alle nuove generazioni e rispetto delle stagioni e dei territori. La cucina italiana è la “cucina degli affetti”: trasmette memoria, cura, relazioni e identità, raccontando storie di famiglie e comunità attraverso il cibo. Riflette il legame tra paesaggi naturali e comunità, incarnando memoria, quotidianità e cultura dei territori». Valori che non possono che essere condivisi, e che certamente fanno parte di quel concetto mutevole, in movimento e aperto a interpretazioni plurali che è la cucina italiana. Attenzione però a non confonderli con la cucina che nutre l’Italia oggi.
Sono davvero questi i valori che guidano la relazione quotidiana con il cibo nel nostro Paese? Oppure siamo davanti a un bel racconto, a una rappresentazione che fa propri temi cruciali per una sana relazione con le filiere alimentari, per poi utilizzarli come strumenti di marketing e leve commerciali?
di Ferdinando Cotugno *
(24 novembre 2025) La COP30 è finita nel pomeriggio, il suo anticlimax ci ha privato del terzo atto, ci ha tolto una sintesi politica ed emotiva che desse un senso ai suoi risultati.
La conferenza sul clima di Belém è finita portando a casa quello che si poteva, cioè così poco da rasentare il nulla, con l'illusione di aver protetto il multilateralismo, ed è da qui che sento il bisogno di partire, prima di analizzare i risultati, i dettagli, i pacchetti e le decisioni sancite col martelletto.
Il commento quasi unanime della società civile, quelli che ci tengono e che sputano il sangue e producono idee e politica ogni settimana dell'anno, è che il compromesso finale è sì al ribasso, ma almeno abbiamo salvato il processo multilaterale, mandando un segnale a Trump. Io, pur rispettando questa posizione, e pur comprendendo quanto questa posizione provi a essere costruttiva, non sono proprio d'accordo.
di Federico Zappini *
Capita che quando il Presidente Fugatti deve affrontare un tema spinoso – dati economici non esaltanti, la “grana” sul terzo mandato, la difesa a oltranza degli aumenti ai consiglieri regionali – la sua strategia sia quella di aprire un fronte a lui più comodo. E’ il caso in questi giorni del nuovo annuncio in merito al “Centro di permanenza e per il rimpatrio” (CPR) da realizzare a Trento.
Il presidente Fugatti – lo rivendica spesso – è persona semplice che non ha tempo né volontà di approfondire il fatto che per i cittadini che commettono reati esistano i tribunali e successivamente le carceri (pur se stabilmente sovraffollate) e che i CPR dovrebbero rispondere – e lo fanno male, molto male… – all’esigenza di espellere chi in Italia si trova senza documenti. Tra questi, potenzialmente, qualche centinaio di migliaia di lavoratori impegnati in Italia e anche in Trentino nei settori più in ombra, e mal pagati, dell’economia.
Ma a Fugatti questo interessa relativamente perché per lui – così come per la presidente Meloni – ciò che conta è l’impatto mediatico di una dichiarazione da offrire a comunità che, sotto l’effetto di un contesto economico e sociale a dir poco incerto, sono sensibili alla promessa di agire con la forza verso chi da decenni viene descritto come nemico.
Report sul terzo incontro (in presenza) del Collettivo di scrittura
Matese, 25 - 28 settembre 2025
Il terzo incontro del Collettivo di scrittura nato a partire dalla pubblicazione di “Inverno liquido” si è svolto a fine settembre a Pietraroja (Benevento) e ha visto la partecipazione di Mauro Arnone, Giuliano Beltrami, Micaela Bertoldi, Antonio Cherchi, Maurizio Dematteis, Guido Lavorgna, Alessandro Mengoli, Nino Pascale, Rita Salvatore, Luca Serenthà e chi scrive.
Siamo nel Matese, una delle aree interne del Mezzogiorno che sarà oggetto di indagine nella pubblicazione della Collana di Derive Approdi dedicata all'impatto delle crisi sugli ecosistemi, relativa alla rinascita delle terre alte attraverso il patto politico fra chi sceglie di restare, chi arrivando trova buone ragioni per immaginarvi il proprio futuro e chi sceglie di ritornare dopo una vita realizzata altrove portandosi appresso un bagaglio di esperienze da mettere in gioco.
Sarà il motivo principale che attraverserà questi quattro giorni di immersione in territori spesso segnati dall'abbandono, niente affatto poveri, semmai impoveriti a cominciare da una malintesa idea di modernità e di sviluppo, dalla mancanza di istituzioni di autogoverno e da modelli di sviluppo importati e che avevano e continuano ad avere ben poco a che fare con la ricchezza culturale e materiale di queste terre.
Sono quasi cinque mesi che Ali Rashid ci ha lasciati. Un vuoto che, personalmente, avverto forse in maniera ancora più acuta in questi giorni di travolgenti manifestazioni. Che pongono l'ingiustizia come tratto insopportabile di un mondo alla deriva e la Palestina come questione morale del nostro tempo.
Un tempo che per Ali corrispondeva a quello del suo percorso esistenziale. Quella vita che, in un racconto senza ritrosie, avrebbe potuto rappresentare un “romanzo della storia” come lo avrebbe chiamato Predrag Matvejevic. Non un “romanzo storico” per una narrazione spesso retorica del passato, ma «un repertorio di racconti, scene, argomenti», libero di fornire una traccia per quei ragazzi, palestinesi o cittadini del mondo che siano, per orientarsi nella complessità di una vicenda densa di chiaroscuri, eppure tanto tragica da non ammettere esitazioni.
Era diventato il nostro argomento d'incontro. Iniziammo a lavorarci ma poi il dolore per quanto stava accadendo e l'urgenza di stare accanto alla sofferenza della sua gente richiamavano Ali sul palcoscenico della testimonianza che pure sapeva indossare con l'eleganza che gli era naturale. Fino ad esserne travolto.
Rimangono qualche decina di pagine e un po' di appunti per l'indice di un racconto rimasto nelle nostre penne. E frammenti come questo (https://youtu.be/WVXzkv0lDCI) che pure non smettono di emozionarci. (m.n.)
di Simone Casalini *
Dunque, dalla metà del 2026 il Trentino avrà il suo Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) che sarà localizzato appena a sud della Motorizzazione, in una palazzina di sei appartamenti che sarà demolita e ricostruita in chiave Panopticon. Il «sorvegliare e punire» di Michel Foucault è transitato nel «rinchiudere ed espellere» perché oggi il soggetto del castigo non è più il delinquente comune, ma il migrante. Che reca con sé una doppia colpa: essersi affacciato nel continente sbagliato e mostrare segni di devianza.
L’accordo con il ministro dell’Interno Piantedosi per la costituzione del Cpr ha almeno due piani politici di lettura. Nel primo è difficile non riconoscere, per quelli che sono i suoi obiettivi e proclami, il successo del presidente Fugatti. Ottiene la realizzazione del Cpr, che nel suo elettorato è uguale a consenso, e il dimezzamento in prospettiva della quota di rifugiati sul territorio provinciale (da 700 a 350).
Lo siamo in tanti e, pur in maniera diversa, si sente in maniera diffusa la solitudine di un tempo nel quale i corpi intermedi arrancano alle prese con la propria sopravvivenza piuttosto che con l'esigenza di comprenderne i motivi: ascrivibili a ragioni diverse, prima fra tutte «un paradigma di “semplificazione” che ci separa illusoriamente dalla natura, ci rinchiude nei confini nazionali, frammenta i saperi, irrigidisce le identità»[1].
Da più persone e trasversalmente alle legittime appartenenze viene il bisogno di riempire questo vuoto, per darsi un tempo disteso e luoghi di studio e confronto collettivo. In passato avremmo forse potuto catalogare questo bisogno come una dimensione prepolitica, ma a chi scrive appare invece in tutta la sua politicità.
E lo è ancora di più in questi giorni, laddove la distanza fra i luoghi che ci ha consegnato il Novecento e il sentimento di indignazione che ha portato in piazza milioni di persone richiede di abitare con intelligenza lo spazio fra il “non più” e il “non ancora”. Da quando Gaza – come ha scritto Alessandro Baricco – è divenuta una soglia invalicabile e il nome di un certo modo di stare al mondo.
Da qui la proposta di una Comunità di Studio, come forma di resistenza e di rinnovamento culturale che considera l'apprendimento permanente lungo l'intero arco della vita essenziale per essere presenti al proprio tempo.
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Collettivo di scrittura
- Consiglio provinciale 2008-2013
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Il monito della ninfea
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Sicurezza
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi




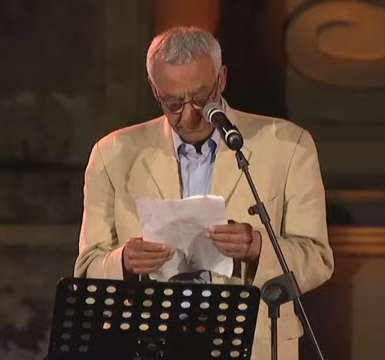
.jpg)