«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Collettivo di scrittura
- Consiglio provinciale 2008-2013
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Il monito della ninfea
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Sicurezza
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi
Ricerca politica
di Raniero La Valle *
Riprendo questo scritto dell'amico Raniero La Valle perché ritengo, pur da non credente, che lo sguardo proposto ci indichi una prospettiva di alto profilo per affrontare questo tempo. Credo altresì che una storia sia finita e che, in mancanza di un'analisi critica della modernità i cui grandi paradigmi sono stati lo stato-nazione e le magnifiche sorti dello sviluppo, ben difficilmente sapremo imparare dal passato e immaginare il futuro. Non tutto è stato scritto e a questo credo dovrebbe servire il tagliando. (m.n.)
(29 novembre 2018) Sono già passati 18 anni dall’inizio del secolo, e anzi del millennio, e le cose avvenute sono tali per cui è diventato urgente fargli il primo tagliando, per capire dove sta andando, e se bisogna lasciarlo andare così.
Era cominciato, il millennio, nella percezione di un grande cambiamento. Con molta retorica era stato celebrato l’Anno Santo del Duemila, stava cominciando l’euro e stava debuttando, col suo nuovo nome di Eurozona, l'Europa, il comunismo non c’era più e il capitalismo stava prendendo il potere in tutto il mondo promettendo libertà e benessere, all’occidentale, per tutti. Grandi (e piccoli) uomini e donne avevano chiuso il passato, ancora appartenendovi, senza sapere o poter aprire il futuro: Paolo VI, papa Wojtyla, Berlinguer, Gorbaciov, e ancora la signora Thatcher, quella che voleva far tornare l’Iraq all’età della pietra, cioè a prima di Babilonia e di Ninive, il Bush del “nuovo secolo americano”, gli autori del Trattato di Maastricht che avevano scelto l’economia al posto della politica e come sovrano il denaro al posto del popolo. In ogni caso però c’era la sensazione profonda di un principio: a Roma si era istituito addirittura un Assessorato che si chiamava “Roma cambia millennio” e si fecero studi e un convegno internazionale per vedere che cosa si dovesse lasciare e che cosa portare con sé nel passaggio dall’una all’altra epoca; poi Rutelli e il cardinale Ruini decisero che bastava così e tutto fu chiuso.
«Tempi interessanti» (87)
Faccio legna per l'inverno...
L'esito delle elezioni in Trentino, per quanto previsto da tempo, non mi è facile da accettare, quasi che dell'impegno di una vita per fare del Trentino una terra diversa non rimanessero che macerie.
Così, negli spazi di tempo fra un appuntamento e l'altro – lunedì ero a Firenze a parlare di cooperazione internazionale, martedì all'Università di Parma a presentare “Sicurezza”, giovedì sera a Isera al primo di una serie di incontri promossi da Slow Food sul rapporto fra cibo e ambiente – faccio provviste e legna per l'inverno, come se la “cattiva stagione” dovesse durare a lungo, almeno una legislatura.
Faccio di tutto, insomma, pur di non prendere in mano carta e penna, laddove pensieri e parole mi sembrano improvvisamente inutili...
... e imitare il salto di Fosbury
di Alberto Winterle e Federico Zappini
Anno 1968. Dick Fosbury vince la gara del salto in alto alle Olimpiadi di Città del Messico. Lo fa stupendo il mondo, modificando per sempre la tecnica di salto. Dalla transizione ventrale si passa a un movimento con l’asticella approcciata di schiena, dopo una rincorsa arrotondata invece che lineare. Un azzardo. Una rivoluzione della tecnica fino ad allora utilizzata.
Osservando il contesto politico e sociale – in Trentino e non solo – risulta evidente l’urgenza di ripercorrere metaforicamente la coraggiosa storia di Dick Fosbury. Un cambio di paradigma, tanto nei contenuti quanto nelle forme, con l’obiettivo di mettere in campo risorse e idee per la definizione di un un nuovo campo possibile per il confronto politico e per l’azione che ne dovrebbe conseguire.
Incontro promosso da Museo Wunderkammer - OFICINA DE INVESTIGACION TEMPORAL
Mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 19.30 via San Martino angolo via Torre d’Augusto a Trento, conversazione con Michele Nardelli.
Il racconto di un viaggio insolito iniziato il 21 marzo dello scorso anno e che si concluderà (forse) nel 2019.
di Federico Zappini *
Scrivo queste righe mentre ancora non si è esaurita la coda dell’allarme maltempo che da giorni tiene in scacco il Trentino insieme a diverse altre regioni italiane. Fuori dalla porta della libreria cade ancora qualche goccia di pioggia. Sul divano della libreria Petra e Adele – le mie due figlie – capiscono solo in parte la causa delle loro prolungata assenza da scuola. Incrocio sui social network le cronache appassionate di amministratori locali che guidano e monitorano, mani e piedi nel fango, i tentativi di rimettere in esercizio vie di comunicazione interrotte, riattivare servizi di base come luce e acqua non garantiti in alcuni casi da giorni, elaborare la conta dei danni e – compito ingrato e doloroso – offrire sostegno a chi ha subito dei lutti.
Siamo quindi ancora nel campo precario di ciò che avviene immediatamente dopo un fenomeno traumatico che impatta su un territorio e sulla comunità che lo abita. Si interrompe il flusso normale della vita. Si incrinano le certezze banali e pur fondamentali della quotidianità. Soffrono le istituzioni – politiche, sociali ed economiche – che ne regolano il funzionamento.
di Federico Zappini *
Si può pensare seriamente di disinteressarsi di una tornata elettorale che riguarda il territorio che si abita, decidendo di osservarla con totale distacco? E’ possibile sorvolare sulle differenze fra le proposte politiche in campo accettando di rimanere alla superficie del dibattito pubblico? La risposta a entrambe le domande è ovviamente no, a meno che non si voglia tentare – inutilmente – di contraddire l’adagio che recita: “se non ti occupi della politica sarà lei ad occuparsi di te”. Non esiste però un unico modo di avvicinarsi al voto (o al non voto, anch’esso un diritto) e fondamentale è proprio il “come” si può – o si sarebbe potuto, o dovuto – approcciare le elezioni provinciali ormai imminenti.
Annunciate come storiche (da qualcuno per la discontinuità che dovrebbero generare, da altri per i danni che potrebbero arrecare al Trentino) appaiono invece deboli proprio nella capacità di determinare innovazione. Da un lato perché tendono a riproporre il ricorrente – e non del tutto onesto intellettualmente, perché totalmente semplificatorio – scontro tra non populisti e populisti, tra europeisti e antieuropeisti, tra buoni e cattivi. Dall’altro perché il grande assente, pur se richiamato in molti modi, è proprio il futuro. É paradossale che la stessa malattia, la retrotopia – un’utopia dallo sguardo bloccato rivolto al passato – , colpisca i due principali fronti che si sfidano, accomunandoli nell’incapacità di uno sguardo visionario e prospettico, progettuale e non emergenziale.
Nel diario del nono itinerario del “Viaggio nella solitudine della politica” (agosto 2018) l'ennesima conferma che questa regione europea continua a trasmetterci suggestioni generalmente incomprese sulla post-modernità*
di Michele Nardelli
Il viaggio che ci porta verso l'Europa di mezzo è estenuante. Le code per lavori di terze o quarte corsie (come se il problema fosse quello di fare spazio piuttosto che di interrogarsi su questi flussi che percorrono l'Europa), il traffico di vacanze esasperate, il rientro di migranti per assecondare radici che col tempo verranno definitivamente tagliate, i confini interni all'Unione Europea – che sulla carta non dovrebbero esserci più – che il vento sovranista vorrebbe ripristinare e quelli che le guerre degli anni '90 hanno sancito insieme all'imbroglio dell'identità nazionale: per arrivare a Kozarska Dubica, al confine fra Croazia e Bosnia Erzegovina, ci impieghiamo quattordici ore.











.jpg)



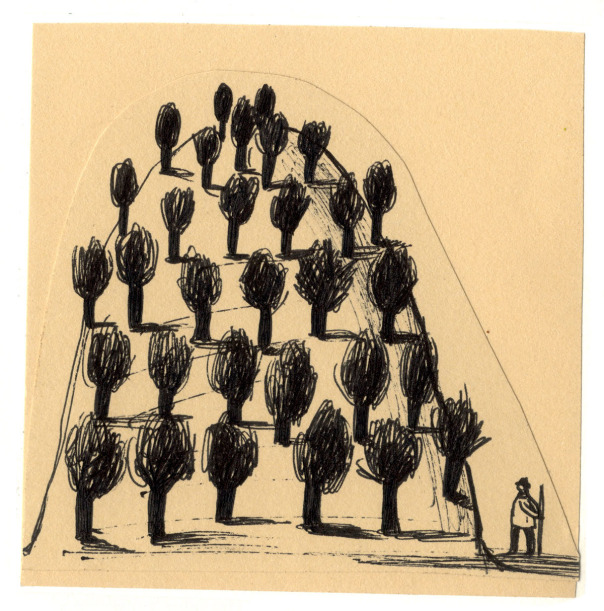

.jpg)