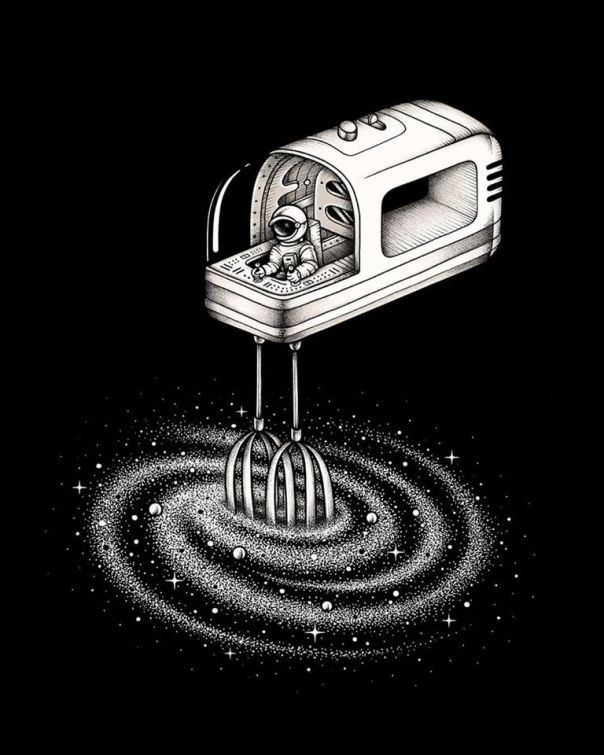Una riflessione sugli effetti sociali di Vaia, sul suo impatto e significato sui diversi versanti delle Dolomiti.
“Il monito della ninfea” è un libro del sociologo Diego Cason e del ricercatore Michele Nardelli, frutto di un anno di incontri nei vari angoli delle Dolomiti, dopo il disastro della tempesta Vaia (autunno 2018). Il sottotitolo del libro, pubblicato da Bertelli Editore, che ha già suscitato l’attenzione della stampa, è eloquente: “Vaia, la montagna, il limite”.
Ospite d’eccezione dell’incontro il Professor Annibale Salsa, profondo conoscitore dell’arco alpino ed autore dell’apprezzatissimo ‘I paesaggi delle Alpi’ (Donzelli Editore).